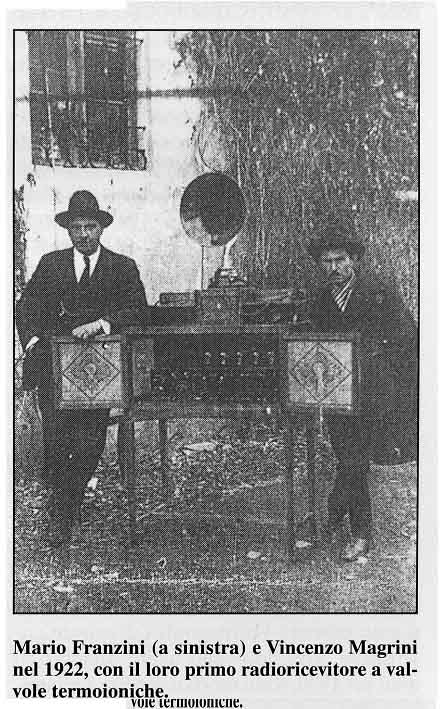 levy
levy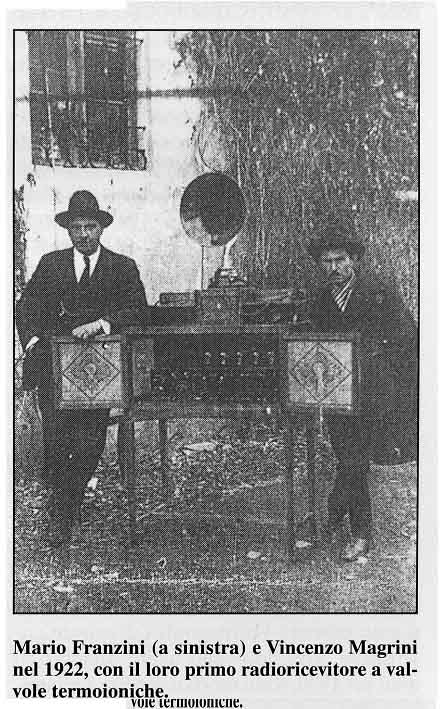 levy
levy

Audionette Levy
L'Audionette della Levy è un
complesso di blocchi elementari che, opportunamente configurati, realizzano
varie tipologie di radioricevitori. La  caratteristica
che distingue questo sistema da altri è l'accoppiamento a radiofrequenza
realizzato con dei trasformatori a nucleo scorrevole costituito da sali di ferro
od in "fer diviseè". Regolandone l'induttanza si otteneva
l'accoppiamento ottimale od addirittura una reazione spontanea dovuta alla
capacità griglia-placca e controllata anche dal circuito risonante prec
caratteristica
che distingue questo sistema da altri è l'accoppiamento a radiofrequenza
realizzato con dei trasformatori a nucleo scorrevole costituito da sali di ferro
od in "fer diviseè". Regolandone l'induttanza si otteneva
l'accoppiamento ottimale od addirittura una reazione spontanea dovuta alla
capacità griglia-placca e controllata anche dal circuito risonante prec edente.
Questo tipo di reazione a variazione di induttanza di placca è uno dei sistemi
ideati dall'americano Armstrong. Il ricevitore in oggetto è uno dei primi in
produzione, precedente a quelli ampliamente reclamizzati in tutte le riviste dal
1923 in poi e si colloca tra il 1919 ed il 1921. E' formato da 7 blocchi
elementari e 5 valvole. Il primo blocco è costituito da un’induttanza
variabile tramite commutatore a bottoni e che serve ad adattare l'antenna al
blocco di accordo. Il blocco di accordo è costituito da un induttanza su telaio
di legno quadrato, avvolta in due strati,
che circonda il condensatore variabile. Una serie di commutatori e ponticelli
permette di usare varie configurazioni di collegamento, compreso il collegamento
con antenna a telaio; naturalmente i blocchi sono connessi l'un l'altro tramite
ponticelli esterni sul lato superiore di ebanite o sul frontale in modo di
realizzare i collegamenti dei filamenti, che non prevedono reostati, e la via
del segnale. Poi ci sono due blocchi in s
edente.
Questo tipo di reazione a variazione di induttanza di placca è uno dei sistemi
ideati dall'americano Armstrong. Il ricevitore in oggetto è uno dei primi in
produzione, precedente a quelli ampliamente reclamizzati in tutte le riviste dal
1923 in poi e si colloca tra il 1919 ed il 1921. E' formato da 7 blocchi
elementari e 5 valvole. Il primo blocco è costituito da un’induttanza
variabile tramite commutatore a bottoni e che serve ad adattare l'antenna al
blocco di accordo. Il blocco di accordo è costituito da un induttanza su telaio
di legno quadrato, avvolta in due strati,
che circonda il condensatore variabile. Una serie di commutatori e ponticelli
permette di usare varie configurazioni di collegamento, compreso il collegamento
con antenna a telaio; naturalmente i blocchi sono connessi l'un l'altro tramite
ponticelli esterni sul lato superiore di ebanite o sul frontale in modo di
realizzare i collegamenti dei filamenti, che non prevedono reostati, e la via
del segnale. Poi ci sono due blocchi in s erie
per l'alta frequenza costituiti dal trasformatore a rf con commutatore per
scegliere due bande di frequenza ed i nuclei di ferro scorrevoli. Naturalmente
il Q di queste bobine non è elevato ma è proprio questo che ne permette i
erie
per l'alta frequenza costituiti dal trasformatore a rf con commutatore per
scegliere due bande di frequenza ed i nuclei di ferro scorrevoli. Naturalmente
il Q di queste bobine non è elevato ma è proprio questo che ne permette i l
funzionamento non critico per una certa banda di frequenza. Il primo,chiaramente
andava regolato in modo che si portasse, interagendo col circuito risonante
d'ingresso, prossimo all'oscillazione nel caso di AM ed in leggera oscillazione
in CW. Naturalmente
a questa condizione influisce anche la temperatura del filamento e la
combinazione induttanza/capacità sul circuito di antenna. In un modello più
recente il blocco dell'accordo di antenna è diverso, non c'è l'induttanza
aggiunta ma viene realizzato un accoppiamento variabile tra una bobina
aperiodica di antenna ed il secondario, regolabile con una manetta esterna. I
blocchi a radiofrequenza c
l
funzionamento non critico per una certa banda di frequenza. Il primo,chiaramente
andava regolato in modo che si portasse, interagendo col circuito risonante
d'ingresso, prossimo all'oscillazione nel caso di AM ed in leggera oscillazione
in CW. Naturalmente
a questa condizione influisce anche la temperatura del filamento e la
combinazione induttanza/capacità sul circuito di antenna. In un modello più
recente il blocco dell'accordo di antenna è diverso, non c'è l'induttanza
aggiunta ma viene realizzato un accoppiamento variabile tra una bobina
aperiodica di antenna ed il secondario, regolabile con una manetta esterna. I
blocchi a radiofrequenza c ontengono
anche due scatoline di ebanite che racchiudono i condensatori a mica di
accoppiamento e la resistenza di fuga. Nei blocchi più recenti tali
condensatori sono in mica, a vista, bloccata da un anello circolare metallico.
Poi il rivelatore che non ha il trasformatore ma solo i condensatori di
accoppiamento e la resistenza di dispersione. I due blocchi audio, identici,
contengono i trasformatori audio, la valvola esterna ed il collegamento per
l'altoparlante.
ontengono
anche due scatoline di ebanite che racchiudono i condensatori a mica di
accoppiamento e la resistenza di fuga. Nei blocchi più recenti tali
condensatori sono in mica, a vista, bloccata da un anello circolare metallico.
Poi il rivelatore che non ha il trasformatore ma solo i condensatori di
accoppiamento e la resistenza di dispersione. I due blocchi audio, identici,
contengono i trasformatori audio, la valvola esterna ed il collegamento per
l'altoparlante.
Mentre è abbastanza chiaro il
funzionamento con un solo stadio e trasformatore di radiofrequenza, due stadi
rendono la faccenda più complicata. Già i progettisti si dovevano scervellare
per poter accoppiare uno stadio a radiofrequenza prima del detector senza
peggiorare l a
situazione, come succedeva di frequente, piuttosto che migliorarla. Due circuiti
a radiofrequenza erano addirittura un’impresa titanica. Questa scelta di Levy
non appare razionale anche se funziona
a
situazione, come succedeva di frequente, piuttosto che migliorarla. Due circuiti
a radiofrequenza erano addirittura un’impresa titanica. Questa scelta di Levy
non appare razionale anche se funziona 
bene: l'influenza e la funzione
del trasformatore della seconda radiofrequenza non è di immediata percezione:
probabilmente influisce un poco come un adattamento di impedenza semiaperiodico ,
ovvero valido per un certo campo d'onda, un poco vede i circuiti risonanti se
pur attraverso le capacità intrinseche di due valvole e contribuisce al
rinforzo. Certo, trovare la presa di antenna più adatta e la combinazione
dell'introduzione
,
ovvero valido per un certo campo d'onda, un poco vede i circuiti risonanti se
pur attraverso le capacità intrinseche di due valvole e contribuisce al
rinforzo. Certo, trovare la presa di antenna più adatta e la combinazione
dell'introduzione dei due nuclei è una faccenda complessa che però porta a grandi prestazioni.
Non per niente l'Audionette era citato tra i "ricevitori a grande
potenza". Questo sistema fu fin dall'inizio dotato da un oscillatore per
eterodina separato che lo treasformava in supereterodina. Tutto l'audionette
funzionava da media frequenza che poteva rimanere fissa od essere variabile.
Collegando la ca
dei due nuclei è una faccenda complessa che però porta a grandi prestazioni.
Non per niente l'Audionette era citato tra i "ricevitori a grande
potenza". Questo sistema fu fin dall'inizio dotato da un oscillatore per
eterodina separato che lo treasformava in supereterodina. Tutto l'audionette
funzionava da media frequenza che poteva rimanere fissa od essere variabile.
Collegando la ca ssetta
dell'oscillatore, o meglio avvicinandola all'ingresso in modo che agisse solo
per induzione, si otteneva in cambiamento di frequenza che ci permetteva di
ascoltare le frequenze somma o sottrazione tra l'oscillatore locale e la media
frequenza. Naturalmente c'era il problema dell'immagine: regolando l'Audionette
come media frequenza a 300 khz, e l'oscillatore ad 1 megahertz, si ricevevano
contemporaneamente 700 e 1300 khz. Se in una delle due frequenze non c'era
niente,nulla di male, altrimenti bisognava collegare tra l'antenna e l'ingresso
del ricevitore un circuito risonante accordabile sui 700 o sui 1300. In
alternativa, senza accordare l'ingresso, si poteva variare l'accordo dell'Audionnette,ovvero
della media frequenza su di una lunghezza d'onda per la quale la somma
ssetta
dell'oscillatore, o meglio avvicinandola all'ingresso in modo che agisse solo
per induzione, si otteneva in cambiamento di frequenza che ci permetteva di
ascoltare le frequenze somma o sottrazione tra l'oscillatore locale e la media
frequenza. Naturalmente c'era il problema dell'immagine: regolando l'Audionette
come media frequenza a 300 khz, e l'oscillatore ad 1 megahertz, si ricevevano
contemporaneamente 700 e 1300 khz. Se in una delle due frequenze non c'era
niente,nulla di male, altrimenti bisognava collegare tra l'antenna e l'ingresso
del ricevitore un circuito risonante accordabile sui 700 o sui 1300. In
alternativa, senza accordare l'ingresso, si poteva variare l'accordo dell'Audionnette,ovvero
della media frequenza su di una lunghezza d'onda per la quale la somma o la sottrazione delle frequenze cascassero una sulla stazione cercata, l'altra
in una zona libera da segnale. Chiaramente la regolazione era complessa, ma
o la sottrazione delle frequenze cascassero una sulla stazione cercata, l'altra
in una zona libera da segnale. Chiaramente la regolazione era complessa, ma  allora
era proprio cosi' comunemente.
allora
era proprio cosi' comunemente.
L’originale che ora appartiene
alla collezione